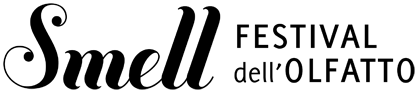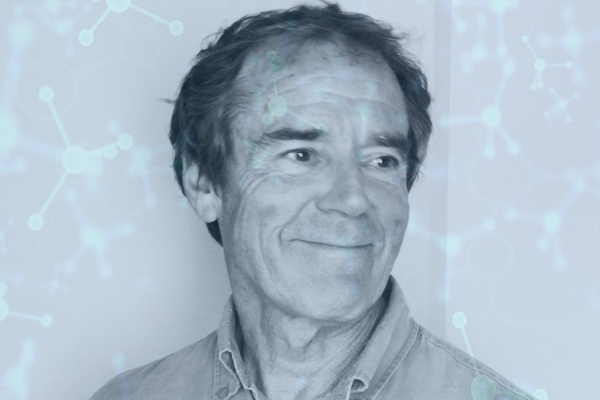
Ospite speciale di Smell Festival 2016, Roland Salesse, ricercatore presso l’Unità di Neurobiologia dell’Olfatto dell’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). A Smell Festival parlerà della valenza culturale ed estetica della percezione degli odori partendo da considerazioni relative alla natura e alla fisiologia dell’olfatto. Roland si occupa da decenni di sensorialità olfattiva spaziando dalla biologia fino alle più recenti applicazioni di questa sfera sensoriale in ambito artistico e teatrale, oggetto anche del suo saggio “Le spectateur olfactif” (in L’Art olfactif contemporain Ed. C. Jaquet, Les Classiques Garnier, Paris, 2015).
Abbiamo chiesto a Roland Salesse di raccontarci meglio il suo lavoro e quello che presenterà a Smell Festival. Ecco cosa ci ha svelato.
Come è nato il suo interesse per il senso dell’olfatto?
(RS) La storia inizia con le molecole, e si conclude sul palcoscenico. Negli anni ‘90, stavo lavorando da tempo sui recettori ormonali. I recettori sono le molecole presenti sulla membrana superficiale delle cellule del nostro corpo. Come il loro nome suggerisce, questi ricevono, intercettano informazioni dalle molecole-segnale che circolano nel sangue. Appena iniziata la reazione a catena molecolare i recettori innescano una risposta cellulare (per esempio, tutte le nostre cellule trasportano i recettori per il noto ormone dell’insulina, secreto dal pancreas; in risposta all’insulina, le cellule prendono lo zucchero dal sangue e lo conservano per ulteriori consumi). Nel 1991, Linda Buck e Richard Axel hanno pubblicato la scoperta di una nuova famiglia di recettori, i recettori olfattivi. Al contrario di molti altri recettori che sono codificati da uno o da un paio di geni nel nostro genoma, i recettori olfattivi hanno un repertorio che ammonta a circa mille geni, e questo li rende la più grande famiglia di geni nel genoma dei mammiferi. Non è così sorprendente, dato che l’olfatto (tranne che negli esseri umani?) gioca un ruolo critico nella sopravvivenza dell’individuo e della specie, vista la sua implicazione nella riproduzione, nell’alimentazione, nelle relazioni sociali e nell’individuazione dell’ambiente. A sottolineare l’importanza di questa scoperta è arrivato poi il premio Nobel, assegnato nel 2004 a Linda Buck e Richard Axel.
Con il bagaglio della mia esperienza di ricerca in laboratorio sui recettori, e dopo questa rivelazione, ci precipitammo ad approfondire il loro studio, un’indagine che si è rivelata la più difficile della mia carriera! Comunque, nel 2006, il nostro lavoro ha portato alla progettazione di tutta una nuova generazione di sensori (in collaborazione con due gruppi italiani di ricerca, a Lecce e a Milano), che abbiamo chiamato “nasi bioelettronici”, in grado di eseguire, ad un costo molto basso, diagnostica non invasiva di malattie, o il monitoraggio ambientale, o il rilevamento di esplosivi o droghe.
Ma, da quel momento, un altro aspetto del mondo dell’olfatto mi affascinò: il breve percorso che va dal naso ai centri cerebrali coinvolti nelle emozioni e nella memoria (per gli specialisti, rispettivamente, l’amigdala e l’ippocampo). Questo processo non è consapevole, cioè, prima ancora di sapere che cosa stiamo odorando, le nostre emozioni e la memoria riconoscono già ciò che quell’odore ha suscitato! Naturalmente si tratta di una proprietà molto allettante, non solo per la ricerca scientifica, ma anche per i ‘rapporti olfattivi umani’, e, infine, per gli artisti. Ecco il motivo per cui, a partire dal 2009 fino ad oggi, ho collaborato ad un progetto di scienze sociali chiamato “Kōdō”, che mira a studiare la creazione olfattiva nelle arti contemporanee, e principalmente in teatro (Kōdō è una cerimonia giapponese dove i partecipanti si incontrano intorno a un maestro per valutare e commentare i preziosi profumi del legno).
Qual è il tema della sua conferenza per Smell Festival 2016?
(RS) Ho proposto un titolo:“Il significato degli odori, dalla biologia al palcoscenico”.In riferimento al tema del festival, “Magiae Naturalis”, mi sono ispirato al libro di Giovanni Battista Della Porta (e in particolare al capitolo IX “De mulierum cosmetica”, ovvero la “cosmetica delle donne”, ma io non sono un latinista) e ho riflettuto che conoscere la natura è un modo intelligente per sovvertire, o arrivare a mete non previste, sia nel campo della scienza che dell’arte. Questo non è nuovo ma è un concetto consolidato nella neurobiologia dove le attitudini cerebrali, selezionate attraverso milioni di anni di evoluzione, possono essere -in un certo modo- “riciclate” per nuove funzioni; un buon esempio di questa attitudine è la lettura, in cui la visione, il linguaggio e le aree motorie sono impegnate per lettere, parole e frasi nella lettura e nella scrittura. Il senso dell’olfatto non sfugge a questo destino. Fin dall’inizio della vita sulla Terra – circa tre o quattro miliardi di anni fa -, e ancor più dopo l’avvento dei vertebrati, circa 500 milioni di anni fa, l’odore è stato coinvolto nella ricerca dell’anima gemella, del cibo, o di una strada sicura nell’ambiente. Da Aristotele in poi, è stato detto più e più volte che l’olfatto è un senso minore, il senso dissoluto negli esseri umani, ma io contesto tale tesi grazie ad un paio di casi. Il primo è la gastronomia. Si ritiene che, se l’uomo ha mantenuto una natura forte del senso dell’olfatto, è perché ha inventato la cottura. Cucinare i cibi non solo aveva ragioni di preservare gli alimenti dal degrado, e di renderli più facili da mangiare, ma alla fine -e forse inaspettatamente all’inizio- di generare nuovi sapori e gusti. La carne cruda ha poco odore, mentre quella cucinata esprime appetitose punte di odori. E l’uomo è forse l’unica specie in grado di godere di questo, grazie al breve percorso tra la bocca e il naso che avviene attraverso la parte posteriore della gola.
Brillat-Savarin aveva già descritto questi concetti 160 anni fa nel suo “Physiologie du Goût”: “Sono convinto che senza l’interposizione degli organi dell’odore, non ci sarebbe una degustazione completa”. Fin dall’antichità, e ora con l’enorme e continua crescita del settore agroalimentare, le proprietà dell’olfatto vengono pienamente sfruttate per il nostro piacere.
Il secondo caso è la profumeria. Come possiamo osservare cosa i profumieri elaborano nelle loro teste? A breve esporrò i risultati ottenuti dai colleghi a Lione. Essi hanno scoperto che gli esperti di profumi spendono meno energia cerebrale nel riconoscere i profumi rispetto ai principianti. Inoltre, la regione della corteccia cerebrale (chiamata corteccia orbitofrontale) coinvolta nella consapevole evocazione degli odori, è più spessa nei profumieri, anche in età avanzata, rispetto al resto della popolazione. Infine, guardando a quanto avviene per i profumieri, è stato dimostrato che le fragranze sono in grado di modificare la loro mente, nonché di suscitare emozioni e ricordi.
Qui arriviamo al punto focale per me: la creazione olfattiva nelle arti contemporanee, e soprattutto negli spettacoli teatrali. In realtà, a teatro il problema principale non è tanto la creatività quanto le questioni tecniche. Nel caso dello spettacolo “Les parfums de l’âme” (“I profumi dell’anima”, creato da Violaine de Carné nel 2012-2013), sei personaggi sono riuniti in una sorta di fabbrica futurista per ricreare l’odore di persone care che non ci sono più. Si tratta di un vero e proprio scenario drammatico che, poco a poco, svela i personaggi e la loro relazione con gli assenti. Dodici diversi odori sono stati diffusi nel corso di questo spettacolo, ponendo il problema dei tempi, degli odori residui che restano nell’aria tra una fragranza sprigionata e l’altra e la ricezione degli spettatori. Ma tuttavia, le composizioni odorose hanno evocano memorie fanciullesche e gli spettatori hanno percepito la “presenza degli assenti”, attraverso il loro odore. Certamente, frequentare gli spettacoli teatrali non era la prima preoccupazione dei nostri antenati, 200 mila anni fa, ma le stesse funzioni olfattive sono in gioco da allora.
Quale crede sarà il ruolo del senso dell’olfatto nella nostra cultura nei prossimi anni?
(RS) La mia collega Annick Le Guerer, che è stata impegnata per anni sul tema della riabilitazione di questo senso, dice spesso che l’olfatto è il senso del futuro. Oggi assistiamo ad una saturazione di tutti i nostri canali sensoriali nella vita di ogni giorno. Dopo aver esaurito le risorse della visione e dell’udito, è il turno dell’olfatto di essere sollecitato: prodotti per la casa e articoli da toeletta, loghi olfattivi, negozi profumati di essenze, pubblicità, automobili ‘odorizzate’, hanno progressivamente invaso il nostro ambiente. Eppure, penso che le principali applicazioni debbano ancora arrivare: la medicina (e soprattutto la prevenzione sanitaria) beneficeranno di speciali impianti di monitoraggio olfattivo non invasivi. Poi emergeranno le applicazioni per la medicina legale, per il rilevamento di esplosivi e droghe. In ultimo, tranne che nella profumeria che molto ha già fatto, le arti olfattive stanno ancora muovendo i primi passi e nuove forme artistiche potranno nascere da tutti gli attuali tentativi sperimentali.
L’EVENTO
Sabato 21 maggio 2016 – Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, strada Maggiore 34 –
“Il significato degli odori, dalla biologia al palcoscenico” – Conferenza di Roland Salesse
Ingresso con biglietto giornaliero € 5,00 – acquistabile il giorno stesso presso la biglietteria del Museo –